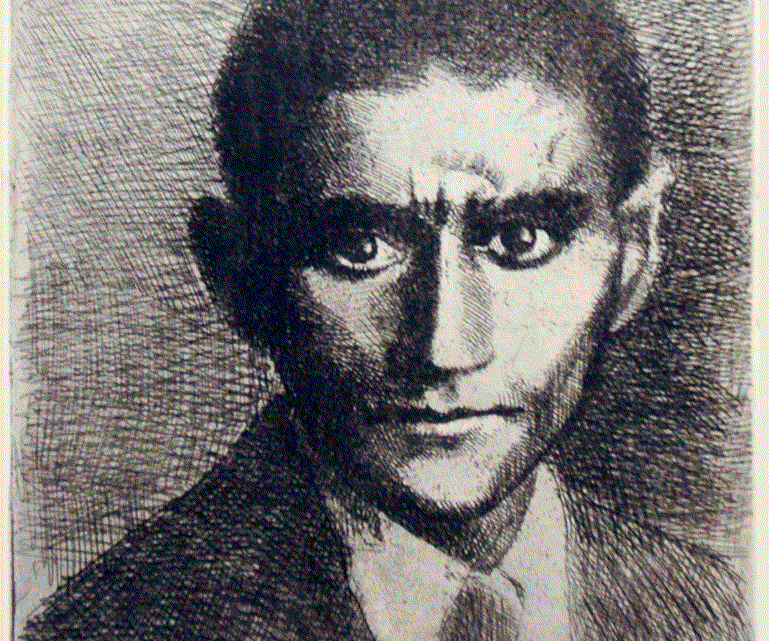
Kafka: fughe da fermo di Luigi Toni
di Luigi Toni
È proprio di ogni grande scrittore inventare nella propria lingua una nuova lingua, una lingua che in qualche modo suoni straniera, ed è appunto questo che intende Kafka, in un’annotazione del 15 dicembre 1910, quando scrive “i miei dubbi stanno in cerchio intorno ad ogni parola e li vedo prima della parola, ma che dico? Non vedo affatto la parola, la invento”. Decostruire la lingua, torcendola, facendo saltare i meccanismi consolidati di quella maggiore, o stabilita. “Essere nella propria lingua come uno straniero” come Il campione di nuoto (“mi trovo nella mia patria […]e che, nonostante i miei sforzi, non capisco una sola parola di quello che qui si dice”) assume una valenza non solo letteraria, ma anche politica.
Si cerca una linea di fuga per sottrarsi al linguaggio del potere, non più in senso feudale, ma diffuso in ogni zona d’intensità, con le sue strategie che attraversano i corpi e le persone, per spingere sempre oltre il controllo e la sorveglianza. Il Panopticon diviene la macchina meravigliosa, atta alla creazione dell’ordine sociale e di corpi docili. Così parlare e scrivere non si collocano più sul versante dell’enunciazione o del nascondimento della verità (intesa come accumulo fiducioso di certezze sul modello della verità scientifica), ma su quello del veicolare segni di potere e sulla loro diffusione. La verità viene ad identificarsi con il potere: Moi la vérité, je parle. Dietro ogni discorso, qualunque sia la struttura logico-linguistica, si nasconde la grammatica di una “tecnologia di potere”. Il potere è ovunque ci sia sapere. Scrivere equivale al divenire, è un processo, un passaggio di vita. Non c’è mai una linea retta, né nelle cose né nel linguaggio. È per questo che bisogna operare dei “buchi nel linguaggio” per vedere cosa sia nascosto dietro. “Non si scrive con le proprie nevrosi”, le nevrosi e le psicosi sono solo “passaggi di vita”, che interrompono il flusso della creazione e della scrittura, oltre il quale non c’è altro che il silenzio. La perfetta salute è quella che permette di vedere cose grandi, forse troppo grandi per cui lo scrittore “torna con gli occhi rossi, i timpani perforati”.
L’oggetto dei racconti kafkiani è quello di tentare di trovare una via d’uscita, non la libertà, concetto troppo grandioso ed altisonante come chiarisce la scimmia, ma solo di tracciare una più perseguibile linea di fuga. Per Kafka ogni invenzione non è altro che un’immagine senza figura. Non è una fantasia, un’illusione, un’allucinazione o una depersonalizzazione, ma una lucidissima rappresentazione e descrizione della realtà. È la metamorfosi che ha preso il posto della metafora. Il divenire-animale come metamorfosi, in quanto “tutto nell’animale è metamorfosi”, presenta la deterritorializzazione assoluta dell’uomo. Il divenire-animale come opposizione al viaggiare (deterritorializzazione parziale), come “viaggio immobile e statico”, viaggio intensivo e non estensivo. Ma non basta il divenire-animale, perché l’animale è “ancora troppo vicino, troppo percettibile, troppo visibile, troppo individuato, troppo territorializzato”. La disperazione, il sentirsi soffocare, che è terribile al di là di ogni pensiero, è scoprire che non c’è più alcuna via d’uscita, o almeno non avere più neanche l’illusione di una via d’uscita (“non avevo altre esigenze; anche se la via d’uscita fosse risultata un’illusione; l’esigenza era così modesta, che l’illusione non poteva essere molto grande”), di non vederla più di fronte a sé, anzi dritta dinanzi a sé. Ogni lotta, perché ogni scrittura è un’arma, deve indirizzarsi contro l’impazienza, che è ancora nel tempo, o meglio è un orizzonte d’aspettativa di fronte al tempo, è ancora il desiderio di salvezza che si affida al tempo, mentre la calma, o come dice la scimmia “senza la massima calma interiore non mi sarei mai potuto salvare”, è collocarsi fuori dal tempo, strapparsi al tempo, mettersi nella disposizione di un’assenza del tempo. Non bisogna cadere nella beffa del trascendente, in Kafka tutto è immanenza, piani strati, slittamenti, scarti laterali (“soltanto una via d’uscita: a destra, a sinistra, purché fosse”), segmenti contigui, linee di fuga.
Non si tratta di sfondare un tetto, non si tratta di colpire con il capo una cassa che si vorrebbe aprire, ma di sfuggire ad una vita che ci condanna alla testa bassa, alla sottomissione burocratica a cui tutto intorno sembra portare, quindi sfuggire alla testa bassa significa trovare una fuga, anche da fermi, uscire dalla macchina della gabbia, rasentarla e scartarla lateralmente in uno spazio contiguo, in un corridoio, in una stanza attigua, in un altro segmento, un segmento che però appartiene sempre alla macchina, perché anche la via d’uscita appartiene ancora alla macchina. Cercare lo sfondamento della struttura, la sua falla, la sua maglia strappata, infilandocisi dentro, lasciandosi con calma scivolare dentro. E scoprire, atterriti, che non resta altro che una fessura troppo piccola per poterci scivolare dentro, il rimanere incagliati dentro una forma, una territorializzazione senza avere la possibilità di deterritorializzarsi è ciò che riempie d’angoscia la scimmia. Segarsi le carni, scorticarsi fino a sanguinare non permetterebbe all’animale di scivolare dentro quella minuscola fenditura della cassa, da cui i suoi occhi possono vedere il mondo esteriore. L’animale sa che deve vincere in primo luogo la propria disperazione di fronte al desiderio della fuga, di per sé impossibile, o meglio inutile, perché sa che nonostante gli scherzi volgari, gli sputi, i colpi di tosse dei carnefici (“al loro riso si univa sempre una tosse che suonava minacciosa ma non significava nulla”), non c’è invero alcun significato reale, anche se questi suonano vagamente come una minaccia. Se il mondo può sempre essere assimilabile ad un “resto”, allora il reale del mondo non può essere pensato se non in termini di numeri frazionari o anche incommensurabili.
Ogni fenomeno rinvia ad una disuguaglianza che lo condiziona. Ogni diversità, ogni mutamento rinvia a una differenza che ne è la ragione sufficiente. Al potere della metafora (che implica sempre un senso proprio o figurato) si sostituisce la destrutturazione e il conseguente dislocamento di senso che porta con sé l’idea della trasformazione. Il divenire-animale non ha mai nulla di metaforico, né presenta alcun simbolismo, alcuna allegoria.
Di fronte all’assenza di vie d’uscita, è l’animale stesso che deve procurarsele. E se le scimmie di Hagenbeck devono restare di fronte ad una cassa, unico orizzonte possibile, unica forma a loro imposta, alla scimmia non resta altro, per trovare una via d’uscita, che di smettere di essere scimmia (”ebbene, allora smisi di esser una scimmia”) e di divenire umano. L’unica via d’uscita è nell’imitazione, non perché la scimmia abbia alcun interesse in questo, in fondo non sarebbe altro che un’ennesima forma irrigidita, un’ennesima territorializzazione, ma un divenire, un passaggio d’intensità, uno scivolamento per sfuggire al giardino zoologico, che non sarebbe altro che una nuova gabbia (“se c’entri, sei perduto”), e scegliere il varietà, unica via d’uscita possibile. Chiudendo la propria relazione, la scimmia stessa rifiuterà ogni giudizio umano, dichiarando di fronte all’Accademia la propria mèta raggiunta, il proprio divulgare cognizioni, il proprio riferire uno stato.
in copertina Franz Kafka,-etching di Jan-Hladík-1978 Creative Commons
